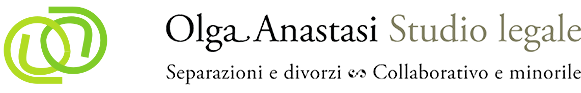Al centro delle regole di un ordinamento sono sempre la persona e lo spazio che gli va riconosciuto in termini di libertà, sicurezza e giustizia. Il modo in cui ciò avviene, dalla nascita in poi, contribuisce auspicabilmente alla crescita di individui felici, con relazioni potenzialmente appaganti, in una comunità capace di costruire pace sociale.
Al centro delle regole di un ordinamento sono sempre la persona e lo spazio che gli va riconosciuto in termini di libertà, sicurezza e giustizia. Il modo in cui ciò avviene, dalla nascita in poi, contribuisce auspicabilmente alla crescita di individui felici, con relazioni potenzialmente appaganti, in una comunità capace di costruire pace sociale.
Il tema proposto sollecita un’indagine su estensione e profondità di due diritti fondamentali, il diritto al rispetto della vita privata e alla riservatezza da una parte, e il diritto all’identità personale dall’altra, in antagonismo quando si tratti di parto anonimo: dunque rispettivamente della situazione soggettiva della donna che abbia generato, manifestando la volontà di non riconoscere il nascituro e di restare ignota, e della condizione di chi invece reclami di conoscere le proprie radici.
Ci muoviamo nell’ambito delle libertà fondamentali: diritti personalissimi, inviolabili, inalienabili, imprescrittibili che vanno sotto il nome di diritti della personalità. Accanto a una trattazione codicistica, quindi, è inevitabile riferirsi ai principi costituzionali e alle norme sovranazionali.
Il diritto a mantenere ignoto il proprio nome, riconosciuto a chi decida di partorire in anonimato, è infatti espressa applicazione dell’articolo 2 della Costituzione, dell’articolo 31 che protegge la maternità, perciò anche la dignità della donna che, per motivi suoi, intenda viverla solo biologicamente, infine dell’articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che tutela il rispetto di ciascuno alla propria vita privata e alla protezione dei dati personali che la riguardano.
Il diritto all’anonimato è disciplinato nel dettaglio dall’articolo 28 della Legge n. 184 del 4 maggio 1983 la quale, nel sancire il principio per cui ogni persona di età minore deve avere una famiglia, stabilisce condizioni e procedure affinché ciò sia garantito quando il minore versi in stato di abbandono. Il segreto sull’identità della partoriente è pertanto protetto sin dalla sala parto, nonché negli immediati passaggi successivi che l’Ufficiale di Stato civile è tenuto a compiere, imponendo nome e cognome al neonato nell’atto di nascita che compilerà dopo aver ricevuto la relativa dichiarazione da “taluno dei soggetti presenti al parto”, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Il minorenne non riconosciuto alla nascita, conseguentemente, potrà ottenere dall’Ufficiale di Stato civile attestazione sulla sua nascita e sulle generalità, senza però alcun riferimento alla madre naturale. Eccezione a tale divieto si ha solo per gravi e comprovati motivi, con legittimazione dei genitori adottivi su autorizzazione del Tribunale per i minorenni o del figlio adottivo che abbia raggiunto il venticinquesimo anno o la maggiore età, quando sussista un serio pericolo per la salute psico-fisica dell’adottato.
Alla base del diritto a conoscere le proprie origini si pone, oltre che l’immancabile articolo 2 della Costituzione, l’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo; la Convenzione di New York del 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, inoltre, nell’affermare il diritto del fanciullo a essere registrato alla nascita e ad avere un nome, specifica che, per quanto possibile, sia di sua spettanza anche conoscere i propri genitori.
Conoscere le proprie origini è species rispetto a un genus più ampio, riconducibile al diritto all’identità personale. Nel Codice Civile troviamo disciplinati espressamente solo il diritto al nome e all’immagine, aspetti di una situazione soggettiva più ampia che, nell’evoluzione della società contemporanea, vede arricchita la varietà di quel complesso di doti che, tutte insieme, consentono il riconoscimento di un individuo e l’unicità in cui egli s’identifica.
Ammettere una persona a quel percorso che ella sente impellente, farle scoprire da dove proviene, chi è sua madre, il grembo che l’ha partorita, è permettere a quell’atto iniziale del generare, atto d’amore, di “farsi diritto, per realizzarsi pienamente” (Stefano Rodotà). Il diritto all’identità personale si esplica pienamente solo quando all’individuo è garantito un livello di salute fisica e psicologica complessivamente intesa: il bisogno di conoscenza delle proprie radici può condizionare infatti gli atteggiamenti intimi, l’equilibrio psichico, la vita di relazione. Si ha bisogno della consapevolezza della propria storia, che è memoria.
Nel dibattito di comparazione tra il diritto della madre a conservare l’anonimato rispetto al diritto del figlio di conoscere le proprie origini, si è trattato di rimuovere gli ostacoli di un’interpretazione restrittiva che, sino a una decina di anni fa, anche da parte del giudice delle leggi, induceva a far prevalere il primo. Sul solco della celebre sentenza della CEDU Godelli contro Italia, dal 2012 in poi, si è assistito invece a un cambiamento di rotta. Con la sentenza n. 278 del 2013, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del comma 7 dell’articolo 28 Legge 184/1983 nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza, la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata.
Per effetto di tale declaratoria, negli anni successivi, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha considerato inefficace la dichiarazione tutte le volte in cui è emerso il decesso della madre naturale che in vita aveva negato l’accesso ai propri dati. In tutti gli altri casi – nell’inerzia del Legislatore sulle modalità di procedura da adottarsi per l’interpello – si è verificato il consolidarsi di due orientamenti contrapposti. Senonché il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, a seguito di nota dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia, nel 2016 ha sollecitato il giudice supremo affinché, trattandosi di argomento di indubbia rilevanza generale e sociale, pronunciasse principio di diritto.
La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 1946 del 2017, superando l’eccessiva rigidità delle letture sino ad allora compiute, ha considerato che la Corte Costituzionale, nel 2013, nel dichiarare l’illegittimità dell’articolo 28 comma 7 Legge 184/1983 ex art. 136 Costituzione, privandolo di immediata efficacia, ha pronunciato sentenza di accoglimento, in dottrina definita “additiva di principio”.
Ciò comporta, ad avviso della Corte, che il giudice, ove richiesto dal figlio adottivo (o nato da parto anonimo) di conoscere le proprie origini, pur in assenza di un intervento normativo in proposito, può valersi del quadro sistematico vigente, procedendo con il rito camerale all’interpello della madre, la cui riservatezza è sempre garantita dalle norme in materia di protezione dei dati personali.
Rispetto alla stessa, peraltro, il lasso di tempo, nelle more trascorso, giustifica certamente un’indagine sulla persistenza del diniego o sull’eventuale intervenuta volontà di revoca. Qualora, tuttavia, il rifiuto a divulgare le proprie generalità permanesse, la pur condivisibile aspirazione del figlio a conoscere la propria storia troverà limite insuperabile nell’intangibilità del diritto all’oblio per colei che lo generò. Cass. SU 2017 n. 1946
In foto Andrea Martinucci, 5092019.jpeg. Acrilico, terra, grafite e alluminio su tela, 200×200 cm, 2019. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.
 Il nome diritto collaborativo è stato coniato per la prima volta da Stuart G. Webb, avvocato in Minnesota, che vive ancora a Minneapolis. Alla fine degli anni Ottanta Stu visse una profonda crisi professionale: da divorzista constatava gli esiti nefasti delle battaglie giudiziarie ingaggiate dalle coppie in crisi e le conseguenze negative sui figli e, stanco, era intenzionato a lasciare l’avvocatura. Racconta di aver seguito, nel 1989, uno dei peggiori casi della sua carriera, con stratagemmi processuali e ostilità di ogni genere, talmente esasperante da indurlo a dedicarsi alla mediazione e a iscriversi addirittura a un altro corso di laurea. Senonché, nello sconforto più totale, poiché la professione gli piaceva quando era in grado di raggiungere un accordo, si disse che non avrebbe mai più varcato un’aula di tribunale e che, per continuare, doveva trovare un modo diverso.
Il nome diritto collaborativo è stato coniato per la prima volta da Stuart G. Webb, avvocato in Minnesota, che vive ancora a Minneapolis. Alla fine degli anni Ottanta Stu visse una profonda crisi professionale: da divorzista constatava gli esiti nefasti delle battaglie giudiziarie ingaggiate dalle coppie in crisi e le conseguenze negative sui figli e, stanco, era intenzionato a lasciare l’avvocatura. Racconta di aver seguito, nel 1989, uno dei peggiori casi della sua carriera, con stratagemmi processuali e ostilità di ogni genere, talmente esasperante da indurlo a dedicarsi alla mediazione e a iscriversi addirittura a un altro corso di laurea. Senonché, nello sconforto più totale, poiché la professione gli piaceva quando era in grado di raggiungere un accordo, si disse che non avrebbe mai più varcato un’aula di tribunale e che, per continuare, doveva trovare un modo diverso.